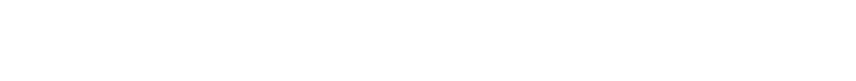Quasi la metà degli indumenti cuciti non viene mai venduta e finisce direttamente in discarica, a volte in un altro continente. La più grande discarica di abiti al mondo sta diventando il deserto di Atacama. È qui che possono finire anche i maglioni con le renne che si trovano sotto l'albero di Natale.
This text has been auto-translated from Polish.
Quando si arriva ad Atacama, si viene investiti dall'aria secca e riscaldata dal deserto. Ma ciò che più colpisce del deserto cileno sono i paesaggi: cosmici, austeri, che ricordano quelli di un altro pianeta. Ci sono lagune colorate, valli lunari, imponenti vulcani e geyser fumanti.
In alto, il cielo è incontaminato e rende Atacama uno dei luoghi migliori della Terra per la ricerca astronomica. In nessun altro luogo le stelle sembrano così vicine come qui, tra le distese desertiche del nord cileno.
Negli ultimi anni, l'immensità incontaminata di Atacama, un'area di dimensioni paragonabili alla Grecia, si è trasformata nella più grande discarica di indumenti del mondo. Nella parte settentrionale del deserto si sta sviluppando un'enorme discarica tessile in cui finiscono ogni anno fino a 60.000 tonnellate di indumenti. Lo spettacolo - rivelato per la prima volta al mondo alla fine del 2021, attraverso una famosa fotografia di Martin Bernetti - è raccapricciante. Tra i paesaggi cosmici e l'ecosistema desertico unico della Terra, atterrano masse di rifiuti tossici provenienti da lontano, soprattutto da Stati Uniti ed Europa.
Scavando tra le crescenti montagne di vestiti, si trovano top colorati di H&M, cappotti autunnali di Zara, jeans di Shein, scarpe Nike e tonnellate di altri prodotti di una varietà di marchi dal suono familiare, compresi quelli più lussuosi. La maggior parte di esse sono europee o americane, anche se ovviamente gli abiti non sono stati cuciti nei Paesi del Nord globale, ma al minor costo possibile nelle sale da cucire del Bangladesh, della Birmania o della Cambogia.
Attivisti e giornalisti locali hanno già iniziato a chiamare questa zona di Atacama cementerio de ropa - un cimitero di vestiti. La gigantesca discarica continua ad espandersi, accumulandosi in montagne crescenti di oggetti e inghiottendo altre parti del deserto.
L'industria tessile è attualmente la seconda industria più dannosa per il clima e l'ambiente (dopo quella dei combustibili). Contribuisce al massiccio inquinamento del suolo e all'avvelenamento dei fiumi (compresi piombo, arsenico e mercurio), consuma almeno il 20% delle risorse idriche mondiali ed emette più del 10% delle emissioni globali di gas serra - più delle emissioni combinate dei voli e dei trasporti internazionali.
La produzione di abbigliamento genera più di 90 milioni di tonnellate di rifiuti sintetici all'anno e rappresenta il 10% della microplastica che galleggia negli oceani. Inoltre, solo il 12% della massa totale di abiti "usati", restituiti o invenduti viene effettivamente riciclato e solo l'1% viene rimesso in circolazione come nuovo tessuto. Questo perché la lavorazione è costosa e complicata: la maggior parte degli indumenti oggi è cucita con i materiali sintetici più economici (principalmente poliestere, acrilico e nylon) o con miscele di tessuti naturali e sintetici difficili da lavorare. I vestiti di plastica dei marchi globali impiegano diverse centinaia di anni per decomporsi.
Una delle prime aziende che negli ultimi decenni ha puntato decisamente sulla quantità a scapito della qualità, imprimendo al cucito un ritmo sostenuto, è stata la spagnola ZARA. È nel contesto di questo marchio che è nato il termine fast fashion, utilizzato per la prima volta sulle pagine del New York Times nei primi anni Novanta. Era il periodo in cui l'azienda di Amacio Ortega, oggi uno degli uomini più ricchi del pianeta, si affacciava sul mercato americano, aprendo la sua prima boutique a New York. ZARA iniziò allora a produrre ancora più velocemente e su scala ancora più ampia di prima, rilasciando un prodotto finito sugli scaffali entro soli 15 giorni dalla creazione di un disegno.
Altre aziende, tra cui la svedese H&M, la britannica TOP SHOP e l'irlandese Primark, entrarono presto in concorrenza e, con il pretesto di democratizzare ed egualitarizzare la moda, cominciarono a spingere il consumismo ancora più in là, raccogliendo profitti multimiliardari grazie alla produzione di massa di capi cuciti in condizioni di schiavitù. Molte catene di negozi raggiunsero un ritmo di produzione così assurdamente veloce che iniziarono a introdurre nei negozi non solo poche, ma decine di linee diverse all'anno. E proprio quando sembrava che fosse impossibile produrre in modo più rapido ed economico, sono entrati in gioco marchi come Shein. L'azienda cinese ha triplicato i ricavi dei giganti esistenti e ha portato la velocità e la natura spazzatura dell'industria dell'abbigliamento a un livello ancora più alto.
Si stima che l'industria tessile moderna produca ogni anno più di 100 miliardi di capi di abbigliamento, più del doppio di quelli prodotti solo 20 anni fa. Queste cifre hanno da tempo superato gli indicatori della domanda effettiva, perché - come sottolinea un rapporto commissionato da McKinsey & Company - si cuce così tanto abbigliamento che oltre il 40% dei capi prodotti non viene venduto. Anche se da domani la produzione di abbigliamento venisse improvvisamente bloccata in tutto il mondo, in pochi anni ci sarebbe ancora una quantità di abiti pari a diverse volte quella che la Terra potrebbe ospitare in modo sicuro e che le persone potrebbero smaltire.
Il prezzo più alto dell'arricchimento delle multinazionali e del consumo eccessivo del Nord globale è pagato dal Sud globale. Questo è stato brillantemente descritto, ad esempio, da Aja Barber nel suo libro Consumed. La necessità di un cambiamento collettivo: colonialismo, cambiamento climatico e consumismo. "La moda approfondisce e perpetua il ciclo di sfruttamento e oppressione. In definitiva, minaccia e danneggia soprattutto coloro che si trovano all'inizio e alla fine di questo ciclo", scrive la ricercatrice statunitense. Le magliette, i pantaloni, le giacche o le borse prodotte in eccesso vengono spesso bruciate o trasformate in rifiuti tossici per l'ambiente, scaricati in Africa (anche in discariche chilometriche in Kenya, Ghana o Nigeria) o nei luoghi da cui provengono originariamente, come Cina e Bangladesh. Oppure ad Atacama, dove le discariche di indumenti indesiderati sono ormai così grandi da poter essere viste dallo spazio.
Come finiscono i vestiti nel deserto cileno? Tutto ha inizio a Iquique, la capitale di una delle regioni più settentrionali del Cile e uno dei porti più importanti del Paese. Qui si trova la più grande zona portuale duty-free del Sud America, la ZOFRI (Zona Franca de Iquique). Qui arrivano ogni giorno prodotti importati. Tra questi, tonnellate di vestiti nuovi, mai venduti, di seconda mano o restituiti. Arrivano qui soprattutto dagli Stati Uniti e dall'Europa - il Cile è rimasto per anni il più grande importatore di prodotti tessili del continente.
In teoria, secondo le norme del Paese, gli abiti importati possono essere lavorati o venduti. Tuttavia, le aziende di abbigliamento non hanno interesse a investire nel riciclaggio o nell'upcycling, nello smaltimento sicuro dei tessuti o nella loro rivendita. Si tratta di un'attività che richiede troppa manodopera e costi elevati. Per le grandi aziende è molto più redditizio sbarazzarsi del problema: spedire gli abiti in Sud America e abbandonarli in un deserto remoto.
Tanto più che la legge esistente lo consente e l'area di Atacama rimane una zona esente da imposte, il che la rende un luogo particolarmente attraente per lo stoccaggio dei rifiuti. I tessuti abbandonati possono giacere qui per anni, senza costi aggiuntivi e senza conseguenze spiacevoli per i produttori.
Le conseguenze sono a carico dell'ecosistema e dei residenti locali. "La nostra città si è trasformata in una discarica per il mondo. Solo il 15% degli abiti importati viene rivenduto qui, l'85% finisce in discariche illegali". - ha fatto appello due anni fa a Patricio Ferreira Rivera, sindaco della città di Alto Hospicio, vicino alla quale crescono montagne di rifiuti tessili.
La vicinanza delle discariche danneggia i residenti. Una serie di sostanze chimiche e microplastiche vengono rilasciate dai vestiti, avvelenando i terreni vicini e le poche fonti d'acqua (il nord del Cile sta lottando da anni per far fronte a una continua siccità). Nelle discariche si verificano spesso incendi, durante i quali fuoriescono nubi di sostanze tossiche. "Chiediamo un cambiamento della legge e degli accordi commerciali in vigore. Non abbiamo le risorse necessarie per risolvere questo problema. Non si tratta di piccole discariche: sono tonnellate di vestiti che continuano a essere trasportate nel deserto e a inquinare l'intera area, nonostante le proteste. Ne abbiamo abbastanza", spiega Ferreira Rivera da mesi.
Con una popolazione di oltre 140.000 abitanti, l'Alto Hospicio - come la vicina zona di Atacama - è diventato negli ultimi anni una cosiddetta "zona di sacrificio" (sacrifice zone) - un'area altamente esposta all'inquinamento ambientale e all'impatto delle sostanze tossiche o dei rifiuti presenti nelle vicinanze. Le zone di sacrificio, ha scritto lo scorso anno il sociologo statunitense Ryan Juskus, sono caratterizzate da un inquinamento industriale sproporzionato e sono vittime di una serie di "effetti collaterali" industriali dannosi per la natura, la vita e la salute umana. A causa della contaminazione ambientale, i residenti di questi luoghi hanno anche maggiori probabilità di sviluppare cancro, malattie respiratorie, ictus o problemi cardiaci.
Secondo un rapporto delle Nazioni Unite del 2022, quasi 9 milioni di persone in tutto il mondo vivono attualmente in zone sacrificali, e non sempre nel Sud del mondo. Uno dei luoghi più contaminati in cui vivere è il "Paese più ricco del Terzo Mondo" (come ha scritto Charlie Le Duff), gli Stati Uniti. Si tratta della cosiddetta Cancer Alley (Via del cancro) in Louisiana, che si estende lungo il fiume Mississippi tra i sobborghi di New Orleans e la città di Baton Rouge.
Lungo un tratto di quasi 130 chilometri si trovano ben 150 raffinerie e fabbriche. Le loro attività fanno sì che l'aria respirata dai residenti (soprattutto afroamericani) sia contaminata dall'ossido di etilene, una tossina cancerogena responsabile, tra l'altro, di problemi di fertilità e danni al DNA. Le misurazioni effettuate qualche mese fa hanno mostrato che i livelli di questa sostanza nell'aria sono ancora più alti di quanto si pensasse, superando di gran lunga gli standard accettabili, e che i residenti hanno decine di volte più probabilità di sviluppare il cancro rispetto ad altre zone del Paese.
L'emergere di queste zone di sacrificio è strettamente legato all'ampliamento delle disuguaglianze sociali. A un polo c'è il gruppo che si arricchisce abbondantemente grazie alla forte espansione di una particolare industria; all'altro c'è il gruppo che tende a essere tra i più svantaggiati economicamente e che diventa ancora più povero sotto l'impatto del crescente inquinamento.
Gli abitanti delle zone di sacrificio tendono a essere persone a basso reddito appartenenti alle classi sociali meno privilegiate - è il caso della Louisiana e lo stesso vale per Alto Hospicio, che per anni è rimasto uno dei luoghi più poveri del Cile. Oggi sta diventando una città di migranti, provenienti tra l'altro dal Venezuela e dalla Bolivia. In Cile, questa è la sesta zona di dedicazione "ufficiale" - le altre sono Quintero-Puchuncaví, Coronel e Mejillones nel Cile centrale e Tocopilla e Huasco nel nord.
Nel 2022, quando il cimitero degli abiti divenne noto al mondo, si decise di eliminare il problema: ci fu un enorme incendio in cui venne bruciata gran parte dei tessuti raccolti. "Per diversi giorni l'intera area è stata invasa da un fumo soffocante, tutto puzzava di plastica bruciata ed era impossibile respirare", racconta Ángela Astudillo, una donna che ha vissuto a Roma. - Ángela Astudillo, studentessa di legge e attivista di Alto Hospicio, ha dichiarato in un'intervista a El Pais. "In seguito i media hanno riportato che il problema era stato risolto, ma non è vero. Tonnellate di prodotti tessili continuano a essere scaricate in Atacama. Le discariche non sono scomparse, si sono semplicemente spostate più in là nel deserto, in modo da essere più difficili da individuare", afferma l'autrice.
L'attivista ammette che quando ha visto per la prima volta con i suoi occhi i cumuli di abiti firmati in mezzo al deserto, è rimasta inorridita; un senso di impotenza, tristezza e profonda assurdità l'ha investita. Ha deciso di agire e nel 2020, insieme a tre amici, ha fondato la ONG Desierto Vestido. In essa si occupa di educazione al clima e di insegnare il consumo responsabile, di progettare moda circolare e, soprattutto, di lavorare sul campo, ripulendo il deserto dai rifiuti tessili.
Nell'aprile di quest'anno, Desierto Vestido ha unito le forze con il collettivo di moda Fashion Revolution Brazil e l'agenzia di marketing brasiliana Artplan, organizzando congiuntamente una serie di sfilate nella discarica - l'Atacama Fashion Week. La collezione è stata creata dall'artista Maya Ramos di San Paolo e tutti i modelli presentati erano basati su abiti provenienti dal deserto. Ángela stessa disegna e crea quotidianamente capi di abbigliamento riciclati. Viaggia regolarmente attraverso le discariche riciclate, documentandole con fotografie e raccogliendo oggetti abbandonati per dar loro una seconda vita.
"Quando si inizia a creare qualcosa da oggetti che qualcuno ha gettato via, la definizione di rifiuto diventa relativa. Se si trova il modo giusto, si può creare qualcosa di veramente grandioso. E allo stesso tempo aiutare almeno un po' il nostro deserto e invertire il suo tragico destino". - dice Ángela, che non ha intenzione di arrendersi nel suo lavoro. Vuole andare avanti finché non avrà successo, anche se finora né i progetti del Desierto Vestido, né le azioni dei consiglieri e degli avvocati locali, né le proteste dei residenti hanno sortito alcun effetto.
Alto Hospicio, situato alla periferia del lungo paese, a più di 1.500 chilometri da Santiago, è ancora abbandonato a se stesso. Navi cariche di vestiti invenduti continuano a salpare verso il Cile.