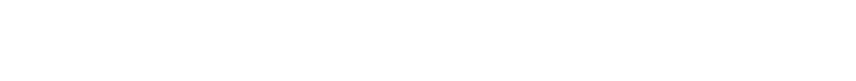Nessuno può pretendere che io mi prenda cura di mia madre giorno e notte, che la lavi e le cambi i pannolini, mi dispiace molto. So che molte donne lo fanno, che si sentono obbligate a farlo, ma non è così che dovrebbe apparire la società progressista e democratica che sogniamo.
This text has been auto-translated from Polish.
Michał Sutowski: In La vita, la vecchiaia e la morte di una donna del popolo lei evoca una scena molto eloquente: suo fratello, in visita alla madre, si lamenta del fatto che lei non ha ancora steso i suoi vestiti dopo il lavaggio. Sul divano accanto a lui siede la moglie, una donna francese di origine africana. La madre risponde che ha già 80 anni ed è difficile per lei, ma in fondo è la moglie che dovrebbe fare il bucato. E aggiunge che a cosa si è arrivati, che i bianchi devono lavorare al posto dei neri! Qui abbiamo un'intera famiglia della classe popolare che lavora duramente, stereotipi di genere e razzismo - ma la causa di cosa?
Didier Eribon: Tutti questi aspetti si intersecano e si intrecciano l'uno con l'altro. Questa scena in realtà mostra contemporaneamente diverse dimensioni della loro situazione, ma volevo soprattutto sottolineare che mia madre è stata razzista per tutta la vita. Anche se era figlia di un immigrato dall'Andalusia, e a volte le piaceva persino sottolineare che aveva sangue "gitano", si lamentava costantemente degli immigrati in Francia. Diceva cose terribili su di loro.
Lo stereotipo vuole che gli operai francesi siano diventati razzisti di destra - invece di votare per i comunisti, hanno iniziato a votare per la famiglia Le Pen - solo dopo il crollo delle fabbriche la sinistra li ha abbandonati in nome del neoliberismo, dell'emancipazione di donne e gay e di tutto il multiculturalismo. .
No, ricordo queste dichiarazioni razziste di molto tempo fa, e non riesco a capire da dove provenga questo razzismo tra la classe operaia francese, non solo francese, tra l'altro. L'unica cosa che mi viene in mente nel caso di mia madre è che si è sentita inferiore per tutta la vita. Era una mezza orfana, avrebbe avuto una madre, che però l'ha affidata a un orfanotrofio. A 14 anni è diventata cameriera in case borghesi - questo è quello che le hanno mandato a fare da quell'orfanotrofio. Poi iniziò a lavorare in una fabbrica, in una fabbrica di vetro, in condizioni molto difficili. Tutto il mondo, tutto il sistema sociale la guardava dall'alto in basso.
E anche lei voleva guardare qualcuno dall'alto in basso.
Penso che si sia sentita innalzata da qualcuno quando ha detto cose sprezzanti sui neri o sulle persone del Medio Oriente. Quando mi ha raccontato questa storia con il figlio e la nuora al telefono, ho cercato di resistere: mamma, non puoi dire cose del genere, non era meglio dirgli di uscire dalla lavatrice e stendere il bucato da solo?
Beh, immagino che questa sarebbe una risposta sensata da parte di una madre ottantenne a suo figlio in una situazione del genere? .
Se non fosse che mio fratello è uno sciocco, incredibilmente orgoglioso della sua mascolinità, per cui per lui mascolinità significa non fare il bucato perché è un lavoro da donne. Ecco perché non riesco a trovarmi psicologicamente in una situazione del genere, vivo in un mondo completamente diverso: vado alle manifestazioni contro il razzismo, faccio il bucato da sola.... Per capirlo e descriverlo, non per giustificarlo, devo ancora sciogliere l'intero nodo di classe, razza e genere.
Ricordi nel libro quello che Simone de Beauvoir ha scritto sul 'secondo sesso': nonostante tutta la specificità culturale della posizione delle donne, alla fine lei si rifaceva a categorie economiche alla 'sfruttamento' come strumento per descrivere la situazione. Questo non si adatta alla situazione di sua madre?
Penso di sì, cioè alla fine il suo comportamento può essere spiegato meglio dal punto di vista sociologico. Non ha potuto frequentare la scuola secondaria perché, da un lato, proveniva da un orfanotrofio e, dall'altro, è scoppiata la guerra - e dentro di sé aveva molti rimpianti per non aver continuato gli studi. Non parlo nemmeno di andare all'università, ma non riuscì nemmeno a completare un corso di dattilografia: una donna di una delle case benestanti in cui sua madre aveva prestato servizio da bambina voleva pagare la sua istruzione. La madre la adorava, ma dopo un anno l'orfanotrofio, secondo le regole, la indirizzò a un'altra casa e lei perse quella possibilità.
Per questo penso che la sua mentalità, il suo modo di pensare, le sue emozioni - tutto questo è stato plasmato dalla sua posizione di classe. E anche le sue reazioni. Certo, con il tempo ha reagito con rabbia anche alla vista di "troppi neri" in un talk show televisivo, ma comunque quella storia lì, con il figlio e la nuora, in fondo riguardava il lavoro gravoso, su chi dovesse effettivamente svolgerlo. Anche se a questo si sovrappone lo stereotipo della divisione dei compiti tra uomini e donne, cioè la gerarchia di genere e quella razziale.
Lei sottolinea più volte che la coscienza dei lavoratori durante la sua infanzia - negli anni Cinquanta e Sessanta - era plasmata da grandi organizzazioni di massa come il sindacato CGT e il Partito Comunista Francese. Non avevano un programma antirazzista e internazionalista? .
Ce l'avevano, i loro leader, come Georges Marchais o prima ancora Jacques Duclos, erano ufficialmente antirazzisti, anche se raramente sollevavano questi temi nei loro discorsi o nei comizi. Ma il voto di mia madre per la sinistra e la sua affiliazione politica non si traducevano affatto in convinzioni e sentimenti personali nei confronti delle persone provenienti dall'Africa settentrionale o subsahariana. E nell'altro senso, le sue opinioni personali sull'argomento non influenzavano il modo in cui votava o partecipava alle manifestazioni. I miei genitori potevano anche andare a una dimostrazione sindacale in difesa dell'indipendenza algerina - e rimanere comunque razzisti.
E sua madre aveva compagni di lavoro non bianchi in quella fabbrica di vetro?
Certo che sì: allora non c'erano molti neri, ma gli algerini, per esempio, erano già abbastanza numerosi. Mia madre lavorava a fianco di questi immigrati, faceva scioperi, spesso indetti dai sindacati comunisti, ed era orgogliosa di lottare per i loro diritti, per ottenere salari e condizioni di lavoro migliori. Eppure non le piacevano, neri o algerini, anche se so che all'epoca dello sciopero non aveva molta importanza. Ma quando, in età avanzata, diceva qualcosa su di loro, respingeva sempre le mie osservazioni: sono a casa mia, posso dire quello che voglio.
Annie Ernaux ricorda i suoi genitori, piccoli negozianti della campagna francese, che sostenevano molto le sue aspirazioni educative, soprattutto sua madre. Per lei è stato diverso? I suoi genitori erano scettici?
Forse non scettici: mi hanno sostenuto quando frequentavo il liceo, e mia madre all'epoca faceva due lavori, fuori dalla fabbrica, distribuendo volantini. Coinvolgeva anche me in questo, cosa di cui mi vergognavo, avevo paura che uno dei miei compagni di scuola mi vedesse con lei. Quando ho voluto andare all'università, non ha opposto resistenza. Solo che per i miei genitori la mia immatricolazione era già qualcosa di inimmaginabile; era al di là della loro comprensione. Entrambi speravano che finissi gli studi e andassi a lavorare per contribuire al bilancio familiare. Ed è stato in quel momento che ho lasciato la famiglia. Non volevo abbandonare gli studi per andare a lavorare.
Ma la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70 sono ancora, credo, tempi di avanzamento sociale attraverso l'istruzione, una grande opportunità per i bambini di famiglie che prima non potevano contare su di essa. Per molti genitori, questo era probabilmente importante?
Lo è stato anche per loro, ma dal punto di vista dei miei genitori il mio liceo è stato solo un avanzamento e qualcosa di miracoloso - i miei fratelli maggiori non hanno frequentato il liceo. Ma già la prospettiva di studiare per altri 5-6 anni era troppo per loro. E anche quando ho detto che volevo studiare filosofia.... dal loro punto di vista era una perdita di tempo e di denaro.
Quando ti sei sentito un traditore della tua classe?
Subito e non immediatamente. Perché questo processo di allontanamento dalla mia famiglia e dal mio ambiente è iniziato molto presto, quando avevo 15 o 16 anni. Leggevo Marguerite Duras, i suoi testi sul razzismo e sull'Algeria, ma anche Marx ed Hegel. Tutta la mia famiglia era operaia, ma nessuno leggeva di lotta di classe. Al liceo ho iniziato ad ascoltare anche la musica classica, mia madre mi prendeva in giro perché quando la suonavo con l'adattatore sembrava di essere a messa. Ho frequentato i film di Godard, la Nouvelle Vague cecoslovacca, il cinema brasiliano di Glauber Rocha. Tutto questo mi ha allontanato da loro.
E quando ha capito di appartenere a un altro mondo?
Quando ho lasciato la mia famiglia, la mia città natale e sono andato a Parigi, per studiare filosofia alla Sorbona. Gente diversa, mondo diverso - e poi ancora lavoro come giornalista, scrivendo per i giornali. Solo che non lo vedevo affatto in termini di "tradimento di classe", cioè era proprio così, ma non lo pensavo.
Sei stato un traditore di classe in te stesso, ma non verso te stesso?
Sì, credo che lo fossi. Ma la riflessione su questo mi è venuta molti anni dopo, in realtà solo con Ritorno a Reims, che ho iniziato a scrivere nel 2006 e pubblicato tre anni dopo - a quel punto avevo già cinquant'anni. Certo, ci avevo già pensato, ma è stato solo dopo la morte di mio padre che ho dovuto affrontare seriamente la mia situazione: perché lo odio così tanto? Perché è un omofobo imbranato, è chiaro. Ma anche perché è un operaio senza istruzione. E poi ho cominciato ad affrontare il fatto stesso che la mia distanza dalla mia famiglia derivava da questo desiderio ....
di diventare qualcun altro? .
Qualcuno di diverso, cioè parte di un mondo culturale in cui si va a teatro, si leggono filosofi e si discute di teorie, cosa che nella mia famiglia non è mai avvenuta. E in occasione di questo confronto, ho cominciato a chiedermi perché me ne sono andato e cosa significava che stavo tornando dopo 30 anni. E in che senso sto "tornando", perché in fondo né io c'ero né quella città c'è più. Per svelare e capire tutto questo, utilizzo gli stessi strumenti - sociologia, filosofia, letteratura - per i quali, per conoscerli, ho voluto o dovuto partire.
Quando ho letto di come lei si è avvicinato forse più di tutti nella sua vita cosciente a sua madre - quando si è sentita libera dopo la morte del marito e ha iniziato una relazione in età molto matura - non sono state le teorie sociologiche ad aiutarla a capirla, ma la semplice, o forse straordinaria, empatia. .
In effetti, all'epoca eravamo molto legati. Durante una conversazione al telefono, mia madre chiese cautamente: "Pensi che sia possibile innamorarsi, avendo la mia età?". "E perché me lo chiedi? Ami qualcuno?". Ebbene, alla fine mi disse di sì, ma che non dovevo dirlo ai miei fratelli perché non avrebbero capito. Cominciò a dirmi chi era, che si era innamorata del suo vicino di casa - e in realtà si trattava di una relazione molto intensa tra due persone già ottantenni, per di più lui aveva ancora una moglie con cui viveva in una casa vicina. Mi chiese cosa avrebbe dovuto fare.
Sei favorevole?
Le ho risposto che non avrebbe dovuto chiedermelo, che facesse quello che riteneva giusto e che l'avrebbe resa felice. E lei era felice. Non riuscì a trattenersi e lo disse agli altri figli, che ovviamente si infuriarono. La cosa non è piaciuta loro....
... moralità piccolo borghese? .
Piuttosto la classe operaia - com'è possibile, la madre era pazza, e in generale chi ha visto questo, appena tre anni dopo la morte del padre! Hanno iniziato a mandarmi messaggi dicendo che era impensabile. Ho risposto che non erano affari loro.
Tua madre te l'ha chiesto per prima perché credeva che l'avresti capita? .
Questo è anche ciò che mi ha detto il mio compagno, Geoffroy: "te l'ha detto perché sei gay". E in effetti, dopo che la mia sessualità, la mia emotività, le mie emozioni erano state insultate, derise, stigmatizzate con sensi di colpa, rifiutate per tutta la vita - ero la persona giusta per porre la domanda: cosa devo fare? Da quel momento abbiamo iniziato a parlare molto più spesso al telefono e l'ho anche vista più spesso a Reims. Questo andò avanti per diversi anni.
Sono state la sua felicità e la sua accettazione a farvi avvicinare?
Mia madre è stata infelice per tutta la vita, non le piaceva mio padre, non lo amava, direi addirittura che lo odiava. E questo significa che ha sofferto dall'età di 21 anni fino alla morte di mio padre, per 55 anni di matrimonio. Quando ha incontrato questo ragazzo, si è innamorata fino alle orecchie. Non era solo una vena di gioia: era gelosa e non sopportava che lui non volesse divorziare dalla moglie e trasferirsi da lei. Litigavano continuamente, ma si amavano davvero tanto. Era un periodo migliore anche per noi.
Il suo libro parla dell'invecchiamento in un Paese ricco ma piuttosto diseguale del XXI secolo. Lei ha descritto gli ultimi anni di vita di sua madre, sempre meno indipendente, con i primi sintomi di disturbo mentale, sempre più dipendente dagli altri. Alla fine, quando non poteva più vivere da sola, tu e i tuoi fratelli l'avete convinta a trasferirsi in una casa di riposo pubblica: potevate permettervela, c'era posto e inoltre si dice che quelle private non siano migliori. Una volta era responsabilità della famiglia prendersi cura degli anziani. .
Sì, questo significava in pratica: compito delle figlie, delle nipoti, a volte dei generi.
E ora la gente si trasferisce in altre città, per cui le proporzioni si sono invertite: ci sono molti anziani e pochi giovani. I genitori e i nonni vivono a lungo, ci sono meno bambini da accudire - la famiglia con quattro figli maschi era già una rarità, almeno in città..
È dovere dello Stato, a cui paghiamo le tasse, prendersi cura delle persone non autosufficienti o almeno aiutare i loro parenti a prendersene cura. La struttura della famiglia è cambiata nell'ultimo mezzo secolo, e anche il modo di vivere è cambiato: non c'è più un intero villaggio che cresce i bambini o si prende cura degli anziani, che un tempo erano molto meno numerosi. In un articolo pubblicato sul libro in Polonia, l'autore mi ha chiesto perché non ho portato con me mia madre.
Ci hai pensato? O i tuoi fratelli?".
Uno vive con la sua compagna a Reunion, 700 chilometri a est del Madagascar. L'altro vive in un alloggio sociale in Vallonia. Il terzo con la sua famiglia nel sud-ovest della Francia.
Un signore a Parigi. .
Sì, in un bilocale di 50 metri quadrati. Mi piace molto, ma non c'è molto spazio, e poi mia madre non accetterebbe di vivere lì. Nessuno può pretendere che io mi prenda cura di mia madre giorno e notte, che la lavi e le cambi i pannolini, mi dispiace molto. So che molte donne lo fanno, che si sentono obbligate a farlo, ma non dovrebbe essere così. Nel nostro Paese ci sono molte donne sopra i 50 anni che passano anni a prendersi cura dei genitori, ma questa non è la società progressista e democratica che sogniamo. L'intera storia delle responsabilità familiari consiste nello spostare le soluzioni ai problemi sistemici sui singoli individui e nell'assolvere lo Stato, i politici o i funzionari pubblici dalle loro responsabilità. Perché sì, prendersi cura degli anziani è un dovere dello Stato sociale, è stato inventato per questo, tra le altre cose.
Si suppone che se ne occupi, ma lei scrive che la madre la chiamava di notte, si registrava sulla segreteria telefonica e si lamentava di non potersi muovere, che nessuno vuole prendersi cura di lei e che le infermiere sono perennemente a corto di tempo. .
Sto parlando di case di cura decenti, che impieghino abbastanza personale, medici, infermieri e che offrano condizioni decenti. Penso davvero che questa sia una richiesta politica e che i partiti e i candidati alle elezioni debbano essere chiamati a risponderne. Hanno almeno questo punto all'ordine del giorno? Non si può far ricadere tutto questo sulle spalle delle famiglie. Io non ho nemmeno una moglie perché sono gay, ma non riesco nemmeno a immaginare gli amici di San Francisco o di Londra che si prendono cura dei loro genitori malati a casa. E poi c'è questo recensore che mi chiede perché non mi faccio aiutare da qualcuno. Che cos'è, scusate, il femminismo se si suggerisce come soluzione di assumere una donna polacca espatriata?
Le famiglie polacche assumono donne immigrate dall'est.
La soluzione è il settore pubblico, sovvenzionato e organizzato - luoghi dove i parenti possono visitare i loro genitori e nonni. Nel frattempo, in Francia, la situazione è scandalosa. Questo è stato uno dei motivi per cui ho scritto il libro: mi ha colpito quando ho sentito da mia madre com'è realmente, e poi ho letto com'è l'assistenza agli anziani in Francia. Non si tratta di un problema marginale, perché dagli stessi cambiamenti nella struttura demografica emerge chiaramente che sempre più famiglie ne soffrono.
Nel suo libro, lei scrive del problema dell'espressione dei successivi "popoli maledetti della terra": lavoratori, neri, donne, minoranze sessuali. Tutti hanno lottato o stanno ancora lottando per parlare con la propria voce - per un posto in fabbrica, a casa, negli uffici, nel dibattito pubblico. E ora veniamo a un altro gruppo, gli anziani non autosufficienti....
Che non possono parlare per se stessi. Quando sei un lavoratore, puoi andare a una manifestazione del Primo Maggio, iscriverti a un sindacato, fare uno sciopero. Se sei una donna, puoi essere attiva nel movimento femminista o in diverse comunità di donne. I neri, i gay o i transgender, persino gli immigrati clandestini hanno diverse organizzazioni, movimenti, campagne, possono scrivere petizioni. Se sei come mia madre, costretta a letto in una casa di cura e capisci a malapena cosa succede intorno a te, soffrendo e sapendo che stai per morire, queste sono condizioni inadeguate per mobilitare un'azione collettiva.
Certo che lo sono, ma ci sono, dopo tutto, figli, parenti, sorelle, figlie, generi. Anche altri gruppi che hanno lottato per la soggettività tendevano a delegare la propria voce a qualcun altro: il movimento delle suffragette era composto da donne bianche istruite provenienti da strati borghesi, i partiti socialdemocratici erano dominati da operai specializzati - eppure questi movimenti parlavano per collettività più ampie. Tua madre non ha potuto manifestare, ma in fondo ci sono sempre più persone come te - i loro cari, compresi quelli che si occupano di lei in modo diretto. .
Sì, ma quando si va a trovare la propria madre o la propria nonna in una casa di riposo, non si ha il tempo di conoscere altre famiglie che si trovano in una situazione simile, non è un buon contesto per guadagnare fiducia reciproca e pianificare una manifestazione comune. Veniamo da città diverse, anche da classi sociali diverse, molti di noi non hanno il tempo, la forza o semplicemente il desiderio di organizzarsi per un'azione politica. Queste non sono le condizioni per mobilitare un movimento di protesta.
E come vede il suo ruolo? Lei ha finalmente scritto un libro che ha sfumature politiche. .
Naturalmente, dopo tutto, chiedo più sostegno da parte dello Stato per persone come mia madre. Quando Simone de Beauvoir pubblicò il suo libro sulla vecchiaia nel 1970, disse che voleva essere la voce dei paria - e io sono per la stessa cosa. Essere portavoce di persone che non possono parlare da sole. Non organizzerò un movimento politico, ma almeno posso parlare, pubblicare un libro, rilasciare interviste alla stampa, alla radio e alla televisione.
Nel libro lei invoca la nozione di Pierre Bourdieu: l'"effetto teoria". In altre parole, per far sì che, ad esempio, la classe operaia o il genere emergano come un determinato fenomeno sociale, qualcuno deve prima narrarlo, in altre parole: inquadrare la realtà sociale. .
Per vedere la classe sociale, occorre un concetto di essa, una cornice cognitiva. E una volta che è visibile, la conseguenza può essere un'organizzazione, come i sindacati o un partito politico, e un nuovo modo di giocare il conflitto sociale. Naturalmente si tratta di un processo piuttosto complesso, questi quadri concettuali non sono arbitrari: il punto è che a una certa realtà sociale esistente vengono attribuiti dei significati, e questi significati ci permettono di co-modellare la realtà.
Con la classe ci siamo in qualche modo riusciti, e anche con il genere, credo - questi concetti, quadri cognitivi sono stati seguiti da cambiamenti nella coscienza e nell'organizzazione politica.
Sì, è cominciata a emergere una nuova realtà, anche le donne hanno cominciato a parlare di sé in termini di "noi", anche se prima non era evidente. Ma immagino che lei voglia chiedersi se l'"età" possa essere trattata allo stesso modo, come una nuova categoria.
Può?
Come categoria - politica, intellettuale, culturale - certo che può e deve esserlo. Ma a differenza di queste: classe, genere, razza, ecc. la categoria dell'età non ci costruirà una nuova realtà analoga, per le ragioni che abbiamo già discusso: questo gruppo non si mobiliterà da solo, non può esistere autonomamente, ha bisogno di un qualche portavoce. E non saranno nemmeno le figlie o i generi angosciati che nessuno vuole ascoltare. In alternativa, qualcuno di riconoscibile, qualche grande scrittore, come Annie Ernaux in The Certain Woman, può raccontare questa storia, inquadrare esternamente questa categoria. Scriverà, per esempio, un romanzo su sua madre, che sarà molto letto e premiato - la figlia dirà così qualcosa sia su sua madre sia sul sistema....
Ma ho l'impressione che il problema più grande non sia che qualcuno parli a nome di qualcuno, per qualcuno, una parte per il tutto - perché questa non è una novità in politica. È solo che, alla fine, i "rappresentati" non riescono a dimostrarsi .... produttività? Utilità? Per l'economia? Per la democrazia?
E ancora una volta Simone de Beauvoir si inchina: come una delle chiavi della sua analisi del genere era per lei lo sfruttamento economico, così nel caso degli anziani - improduttività, inutilità. Per questo motivo spingiamo gli anziani ai margini, assegniamo loro un posto nel mondo sociale tale da farli sparire dalla nostra vista. Ma, in fondo, esiste una comunità democratica al di fuori della logica del mercato e del produttivismo.
Quindi? .
In una comunità di questo tipo, le persone "improduttive" meritano di essere assistite, se non altro per il fatto che una volta lavoravano, che pagavano le tasse, che era sulle loro spalle sostenere le famiglie, l'economia, lo Stato. E quindi hanno diritto a una vecchiaia confortevole in una casa di riposo dove non ci sono posti vacanti, dove ci sono medici, infermieri, psichiatri. Ma al di là dei valori democratico-politici, ci sono quelli puramente umanistici: come società abbiamo il dovere di prenderci cura dei più deboli, degli abbandonati, dei più fragili tra noi.
Poiché il mio circolo ha pubblicato i libri di Thomas Piketty in Polonia, devo chiederle qual è il suo atteggiamento nei confronti di questo economista. Sembra che non le piaccia, eppure postula un nuovo socialismo per il XXI secolo!
Piketty è un liberale, un sostenitore della meritocrazia, e il suo primo libro famoso, Capitalismo nel XXI secolo, era molto conservatore. Certo, scrive che la disuguaglianza è troppo alta e che è ingiusta, ma proprio nell'introduzione ammonisce la sinistra per la sua presunta "pigrizia di pensiero" e afferma che, dopo tutto, una certa disuguaglianza è giusta, purché sia basata sul merito o sullo sforzo e sul lavoro.
E non lo sono?
Mia madre viveva come viveva e guadagnava poco perché era una donna della classe operaia, non perché mancasse di merito e si sottraesse al lavoro. Ha lavorato molto duramente, così come mio padre e il resto della mia famiglia. Si potrebbe chiedere lo stesso alla donna che pulisce il suo ufficio all'università: non si impegna abbastanza in questo lavoro? Piketty ha praticamente cancellato la nozione di classe sociale dal suo lavoro; non scrive dell'importanza del capitale culturale per la riproduzione di classe. Tra l'altro, non c'è alcuna teoria del capitale, anche se la parola è presente nel titolo: abbiamo molti dati e cifre che dimostrano che l'eredità è migliore del lavoro.
Come in Balzac, nella scena della conversazione tra Vautrin e Rastignac da Ojec Goriot. .
Tutto questo è vero: il capitale si trasmette di generazione in generazione. Ma come viene prodotto? Sembra aver dimenticato anche il colonialismo. Dopo un'ondata di critiche, anche da parte mia, ha iniziato ad ammettere che sì, le classi sociali esistono. Anche se, allo stesso tempo, non gli piace il "marxismo del XIX secolo". Ma i miei genitori sono riusciti comunque a lavorare in una grande fabbrica, hanno vissuto il conflitto tra lavoro e capitale! Una volta Piketty si è lamentato in un'intervista del fatto che, in quanto accademico, non aveva i soldi per comprarsi un appartamento a Parigi - pare che questo sia stato lo stimolo per scrivere il suo libro. Ma mia madre non poteva comprarsi un appartamento né a Parigi né a Reims, ha vissuto per tutta la vita in case popolari. Ho l'impressione che lui viva una tale opposizione tra le diverse fazioni della borghesia: quella istruita, come lui, e quella dei grandi proprietari immobiliari; ma il mondo delle classi sociali scompare davvero in questo quadro. Questo suo libro mi ha molto, molto infastidito.
**
Didier Eribon - Sociologo e filosofo francese. Lavora all'Università di Amiens e ha insegnato in molte università, tra cui Berkeley, Princeton, Cambridge e Valencia. Ha scritto più di una dozzina di libri di sociologia, filosofia, storia delle idee e studi di genere. Tra le pubblicazioni in polacco figurano una biografia di Michel Foucault, una conversazione con Georges Dumézil Sulle tracce degli indoeuropei. Miti ed epopee, una conversazione con Claude Lévi-Strauss Da vicino e da lontano e Ritorno a Reims. Il libro è stato tradotto in molte lingue e trasferito a teatro più volte, anche da Laurent Hatat, Thomas Ostermeier e Catherine Kalwat. Nel 2024, il suo ultimo libro La vita, la vecchiaia e la morte di una donna del popolo è stato pubblicato in traduzione da Jacek Giszczak.